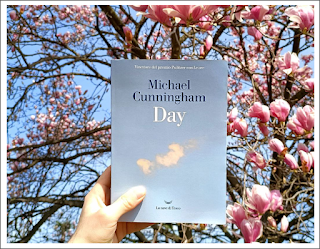Peter Cameron scrive i dialoghi più belli del mondo. È il primo pensiero davanti all'arguzia, alla naturalezza e alla classe dei protagonisti di Quella sera dorata: a detta dei conoscitori, forse il romanzo più memorabile dell'autore americano. Ambientato in Uruguay, in un Eden splendido ma segretamente decadente, segue la missione di un dottorando in odore di pubblicazione: Omar, ventotto anni e tante ambizioni confuse, vorrebbe scrivere la bibliografia di Jules Gund, scrittore da poco morto suicida. Gli eredi, tuttavia, negano fermamente il consenso. Spinto da una fidanzata ben più volitiva di lui, l'aspirante autore vola dal Kansas al Sud America come la Dorothy del Mago di Oz. Al termine del sentiero di mattoni gialli lo aspetta la villa di Ochos Rìos, popolata da strampalati abitanti da persuadere. Su cosa fare leva pur di raggiungere l'obiettivo: il proprio fascino naïf o la compassione?
Lo champagne non è mai uno sbaglio.
Dopo aver indagato i tormenti tardo-adolescenziali del protagonista di Un giorno questo dolore ti sarà utile, a ben vedere vicinissimi a quelli di questo Omar in crisi creativa, Cameron ci delizia con una commedia corale piena di false cortesie e, a dispetto delle conversazioni fittissime, di significativi non detti. Il cast d'insieme comprende: Caroline, la vedova di Gund, ossessionata dal senso di incompiuto della sua vita artistica e matrimoniale; Arden, l'amante, all'apparenza arresasi al ruolo di sfasciafamiglie, ma in realtà desiderosa di innamorarsi ancora; Adam, il fratello omosessuale, che a suon di cinismo nasconde l'amarezza per l'età avanzata e la crisi con Pete, il compagno a cui non sa dare né l'amore né la libertà. Perché si ostinano a restare in quella villa ai confini del mondo, mantenendo integro un assurdo ménage domestico, se il loro collante è ormai venuto meno? Perché la diffidenza verso una biografia autorizzata: paura di cosa potrebbero scoprire del capofamiglia, o di loro stessi?
Sono arrabbiata, Omar, ma questo non esclude l'amore. Le due cose possono coesistere, sai. Sono capace di provare diverse emozioni allo stesso tempo. Sono una persona complessa. La vita è complessa. L'amore è complesso. Non è semplice. Non sono compartimenti stagni.
In anticipo sui tempi, il romanzo ironizza sull'ossessione della verità nella società dell'apparenza — basti pensare al continuo fiorire di biopic sui personaggi dello spettacolo, alla moderna propensione per l'autofiction, ai podcast radiofonici a proposito di crimini e misteri irrisolti — e si sofferma sulle esistenze dei “parenti di”, illuminati di una luce riflessa che non ne dissipa mai a sufficienza le ombre. Purtroppo o per fortuna, quello che succede in Uruguay non resta in Uruguay. Il perturbante arrivo di Omar, infatti, segnerà un prima e un dopo: niente sarà piu lo stesso. Dimenticate, però, le convivenze tossiche dei recenti May December o Saltburn. Lieve, esotico, romanticissimo, Cameron ci culla — e ci cambia — con i calici di rosato, i completi di lino, l'ozioso brusio degli alveari, il profumo soave del glicine in fiore e delle erbe aromatiche. È l'inizio dell'estate. Ci sono le stelle in cielo e, vestiti a festa, ci si attarda a guardarle. Il desiderio espresso? Che ”quella sera dorata” duri in eterno.
Il mio consiglio musicale: Ornella Vanoni – Tristezza